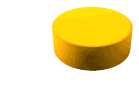Le varie tipologie di formaggio . Le proprietà salutistiche . I
formaggi e i valòori nutrizionali .
Quali formaggi sciegliere e quali evitare . Il contenuto in proteine ,
grassi e glucidi dei formaggi .
Formaggi freschi e Formaggi stagionati .
Il formaggio e la sua storia
Da quando sulla terra apparve la vita esiste il latte, alimento primo dei
mammiferi e quindi
anche dell'uomo. Attraverso i secoli, il miracolo del latte si è rivelato
compiutamente anche
nel suo principale derivato: il formaggio.
Documenti sulle prime dinastie dei re Egiziani e dei Sumeri testimoniano che
la
fabbricazione del formaggio era già conosciuta cinquemila anni orsono.
Plinio, Virgilio,
Omero, Aristotele affermano che era in auge presso i Romani e i Greci.
Probabilmente il formaggio, questo meraviglioso prodotto alimentare, ha
un'origine che si
perde nella notte dei tempi e certo si può collegare al nascere della
pastorizia.
I primi pastori, agli albori della civilizzazione dell'uomo, scoprirono il
formaggio osservando
prima la trasformazione che avviene abbandonando il latte alla sua naturale
fermentazione
acida e successivamente constatando che, con l'aggiunta di porzioni di
stomaco di agnello
(caglio), il latte assumeva consistenza solida (coagulava) ed aveva la
proprietà di
conservarsi.
Nel corso dei secoli scienza e industria hanno fatto di un alimento
primitivo un cibo
raffinato, moltiplicandone tipi, forme e sapori.
Che cosa è il formaggio?
Il formaggio è uno dei cibi più nutrienti che esistano. Esso si può definire
come il prodotto
della maturazione della "cagliata" ottenuta con la coagulazione presamica o
acida del latte
intero e puro o della crema da esso ricavata, o del latte scremato
parzialmente o
totalmente, con la sola aggiunta di fermenti, sale, spezie.
Nonostante che la tecnica della sua preparazione sia estremamente varia e
che si
possano oggi distinguere con nomi diversi centinaia di tipi, il principio
per cui dal latte si
ricava il formaggio è praticamente unico.
Sul latte intero o parzialmente scremato (latte prevalentemente vaccino, ma
anche di
pecora, di capra, di bufala) si fa agire un fermento detto " presame" o "
caglio".
Il " caglio", liquido o in polvere o in pasta, è preparato, con opportuno
trattamento, dal
ventriglio essiccato e stagionato dei vitelli o dei capretti o degli
agnelli.
Sotto l'azione del "caglio", la caseina, la proteina tipica del latte, si
coagula in una massa
granulosa detta "cagliata", la quale oltre alla proteina (caseina) contiene
quantità maggiori
o minori di grasso, a seconda che si sia partiti da latte intero o
parzialmente scremato; la
cagliata contiene i minerali e le vitamine presenti nel latte di partenza.
La cagliata viene lavorata secondo tecniche diverse a seconda del tipo di
formaggio che si
vuol produrre; anche la maturazione del formaggio, quando ha luogo, è
diversa nei modi e
nella durata, pur consistendo sempre in una serie di processi fermentativi.
Da queste diverse manipolazioni tecnologiche hanno origine le differenze tra
i formaggi:
duri o molli, dolci o piccanti, ecc. In dettaglio la fabbricazione del
formaggio avviene
attraverso il succedersi delle seguenti fasi:
1) Riscaldamento del latte intero o scremato;
2) Eventuale aggiunta di fermenti e di coloranti;
3) Coagulazione del latte con il caglio o presame; 4) Rottura del coagulo o
spinatura;
5) Eventuale cottura della cagliata
(formaggi a pasta dura);
6) Estrazione della cagliata e messa in forma;
7) Eventuale compressione delle forme
(formaggi a pasta dura);
8) Salatura;
9) Maturazione o stagionatura.
Allorché viene tolta la cagliata, nella caldaia rimane il siero. Questo
viene utilizzato per la
preparazione della ricotta, portandolo alla temperatura di 80-100 ¡C previa
aggiunta di
siero inacidito (agra).
La ricotta è preparata prevalentemente con latte di pecora, ed in alcune
regioni anche con
latte di mucca.
Il caseificio
Si può definire il complesso dei mezzi necessari alla conservazione e
lavorazione del latte
ed alla fabbricazione del burro e del formaggio. Pur essendo, come si è
detto, questa
industria la più antica del mondo (ne parla anche la Bibbia , e gli antichi
Romani ci hanno
lasciato numerose notizie in merito) è solo nel Medioevo che inizia lo
sviluppo del
caseificio vero e proprio in Europa.
Ed è solo con la comparsa della prima macchina scrematrice centrifuga
(1877), e di altre
macchine che permettono la lavorazione dei sottoprodotti del latte, che
nascono i caseifici
a carattere industriale.
Ecco in sintesi i locali essenziali che sono comuni a tutti i caseifici medi
e piccoli,
tralasciando di considerare tanto i fabbricati necessari agli stabilimenti
maggiori quanto
quelli dei burrifici e delle Centrali del latte, il cui studio di progetto
compete a tecnici
specializzati.
1) Vestibolo o camera di ricevimento del latte
E' il locale in cui avviene il ricevimento del latte e il relativo
controllo, il quale si fa
preferibilmente a peso (peso = vol. x 1,03; vol. = peso x 0,97).
2) Camera del latte
E' il locale nel quale avviene l'affioramento spontaneo della crema e dove
perciò il latte
viene messo a riposare in recipienti larghi ma bassi (bacinelle, navi o
vasche) e nei quali è
lasciato dalle 12 alle 14 ore, a seconda della stagione ed a seconda del
grado di
scrematura voluto. Si trova solamente in quei caseifici che producono
formaggi semigrassi
(ad es. Grana) impiegando latte parzialmente scremato e che abbia raggiunto
la
necessaria " maturanza" per la sopravvenuta acidità fermentativa.
3) Cucina o casone
E' il locale meno esigente in fatto di temperatura e perciò di orientamento,
cosicché è
situato quasi sempre a mezzogiorno, ma è il più ampio e illuminato perché vi
si compiono
tutte le operazioni che costituiscono la prima fase della fabbricazione dei
formaggi. In esso
trovano posto le caldaie (di foggia diversa a seconda del tipo di formaggio
e riscaldabili a
fuoco diretto o col vapore) per conferire al latte la temperatura di
coagulazione o per la
eventuale cottura della cagliata.
4) Salatoio
E' il locale nel quale si svolge la salatura dei formaggi, che si può fare
"a secco",
cospargendo di sale la superficie delle forme, oppure "in salamoia",
immergendo i
formaggi in acqua satura di sale.
E' il locale dove si svolge la maturazione o stagionatura dei formaggi, che
può durare più o
meno a lungo a seconda del tipo di formaggio (il tempo aumenta con la
durezza della
pasta) e che può essere totale o parziale a seconda delle consuetudini.
La lavorazione di taluni formaggi (ad es. provoloni o caciocavalli) esige
pure un reparto per
l'affumicatura.
Come varia molto da regione a regione in Italia la produzione quantitativa
del latte, così
varia la distribuzione dei caseifici.
I formaggi sono prodotti per il 75% nell'Italia settentrionale (Pianura
padana in particolare),
per il 6% nella centrale, per 1'8% nella meridionale e per 1'11% nella
insulare.
Come si classificano i formaggi
Non esiste un'unica classificazione dei formaggi, dato che se ne possono
proporre molte
e diverse, differenziate fra loro a seconda della caratteristica che di
volta in volta si prende
come base di partenza.
Accenniamo alle più significative.
1) I formaggi possono essere distinti in vaccini, pecorini, bufalini e
caprini, a seconda del
tipo di latte che si adopera per produrli.
2) In funzione del metodo di lavorazione si possono ottenere formaggi a
pasta molle (che
contengono più del 40% di acqua) e formaggi a pasta dura (che ne contengono
meno del
40%).
Questi ultimi, poi, a seconda della temperatura alla quale viene portata la
cagliata,
possono essere suddivisi in formaggi crudi, formaggi semi cotti, formaggi
cotti. A parte
sono considerati i formaggi a pasta filata (che vengono manipolati con acqua
calda a 85-
90¡C).
3) Un'altra classificazione può essere fatta in base all'indice di
maturazione del formaggio,
che è dato dal rapporto fra l'azoto solubile e l'azoto totale nel prodotto.
4) Ci si può anche riferire al contenuto in grassi.
Nel nostro Paese un primo decreto legge aveva fissato nel 1925 i limiti di
contenuto in
materia grassa sulla cui base dovevano essere denominati i formaggi
("formaggio grasso"
con un contenuto non inferiore al 42%, riferito alla sostanza secca;
"formaggio magro" con
un contenuto inferiore al 20%; "formaggio semi grasso" con un contenuto
compreso fra 20
e 42%).
Tali denominazioni non sono più richieste da quando, nel 1938, un altro
decreto legge (poi
parzialmente modificato nel 1955) ha stabilito che ogni singolo tipo di
formaggio debba
contenere una percentuale minima di sostanza grassa, non inferiore a quella
indicata in
un'apposita tabella.
5) Per una serie di formaggi italiani, poi, un D.P.R. del 1955 ha stabilito
le denominazioni
di origine (DOC) e di tipicità.
Le denominazioni di origine sono definite dalle zone di produzione, dai
metodi di
lavorazione e da caratteristiche merceologiche.
Le denominazioni di tipicità sono definite dalle pratiche casearie,
utilizzabili in tutto il
territorio nazionale, e dalle proprietà organolettiche e merceologiche.
6) Va infine ricordato che nel marzo 1992, nel quadro del recepimento delle
norme
comunitarie, è entrata in vigore in Italia una norma che consente
(esclusivamente per i
formaggi diversi da quelli DOC e tipici) la libera fabbricazione dei
formaggi "magri" (con
meno del 20% di grassi sulla sostanza secca) e di formaggi "leggeri" (con un
contenuto di
grassi, sulla sostanza secca, compreso fra il 20 e il 38%).
Al contrario, per i formaggi DOC e per i formaggi tipici rimangono validi i
limiti di contenuto
grasso già stabiliti per i diversi tipi.
7) A parte vanno considerati i formaggi fusi, prodotti che si ottengono per
fusione di
formaggi di vario tipo e a diverso stato di maturazione, opportunamente
triturati, ai quali è
possibile anche aggiungere della crema e della caseina, nonché determinate
sostanze in
qualità di fondenti e di addensanti. Specifiche disposizioni di legge
stabiliscono per questi
formaggi un tenore minimo di grassi del 35% sulla sostanza secca, un'umidità
massima
del 55%, un contenuto massimo di ceneri dell'8% e il divieto di qualsiasi
colorazione
artificiale.
Valore alimentare del formaggio
I formaggi vantano un valore nutritivo elevatissimo, dato che possono essere
definiti come
un vero e proprio concentrato (a densità maggiore o minore a seconda del
contenuto in
acqua) delle qualità nutritive del latte (con la sola eccezione del
lattosio).
Se a questo si aggiungono le loro caratteristiche favorevoli di
conservabilità, di ridotto
volume e di facile trasportabilità, si completa il quadro di un alimento
veramente eccellente
sia sotto il profilo del gusto che sotto quello dei pregi nutrizionali. Un
alimento che si presta
straordinariamente a fungere da correttivo delle carenze di certe diete
povere o sbilanciate
e incomplete (come sono, ad esempio, le diete vegetariane estreme) e da
integratore,
particolarmente nella alimentazione dei bambini e delle persone anziane.
I formaggi sono ricchi di energia (sono un vero alimento, non un condimento
o un
complemento al pasto!) e sono un concentrato proteico (fino a dieci volte i
valori del latte
di partenza) di alta qualità: 150 grammi di formaggio bastano a coprire il
fabbisogno
proteico di un adulto, contro i 250- 300 grammi di carne necessari per la
stessa
operazione. Inoltre, la qualità delle proteine del latte è considerata
superiore a quella delle
stesse proteine carnee, ed adattissima, per la sua particolare ricchezza in
certi
amminoacidi essenziali, a compensare le carenze delle proteine vegetali
presenti nella
dieta.
Il maggior contributo al valore energetico dei formaggi è dato dai grassi,
presenti in
quantità diverse a seconda della varietà, ma comunque sempre in notevole
misura,
mentre il colesterolo è presente nei formaggi in misura variabile dai 60 ai
100 milligrammi
ogni 100 grammi (per una assunzione massima giornaliera suggerita di 300
milligrammi).
I relativi problemi di equilibrio nutrizionale possono comunque essere
agevolmente
superati limitando oculatamente le quantità consumate oppure ricorrendo di
preferenza a
prodotti scremati o parzialmente scremati, del tipo di quei formaggi "magri"
o "leggeri" la
cui produzione, dal marzo 1992, è finalmente consentita anche dalla legge
italiana.
La qualità dei grassi presenti nei formaggi è comunque per lo più tale da
renderli
facilmente digeribili e utilizzabili da parte dell'organismo e da conferire
loro ridotte attitudini
ad elevare i livelli di colesterolo nel sangue.
Di grande rilievo anche l'apporto in minerali. I formaggi contengono molto
fosforo, molto
sodio (il che può creare problemi a chi soffre di ipertensione arteriosa),
ma soprattutto
molto calcio, un minerale essenziale per la formazione e il mantenimento
delle ossa e dei
denti e per una serie di processi, quali la conduzione degli impulsi
nervosi, la contrazione
muscolare, la coagulazione del sangue, ecc.
Il formaggio, con il latte e lo yoghurt, è l'unica vera fonte alimentare di
calcio per l'uomo:
questi prodotti assicurano oltre i 2/3 dell'introito giornaliero di calcio
nel nostro Paese, e
bastano 70- 120 grammi di un qualsiasi formaggio per coprire il fabbisogno
quotidiano
medio di un adulto.
Va poi sottolineato che in questi prodotti il calcio stesso è contenuto in
una forma chimica
che lo rende molto più facilmente assorbibile e utilizzabile da parte del
nostro organismo.
Ed è anche importante ricordare che il formaggio contiene calcio e fosforo
in un rapporto
superiore ad 1, ossia in un rapporto ideale sia per una utilizzazione
ottimale del calcio che
per correggere nel complesso della dieta la esagerata prevalenza del fosforo
che si
riscontra in tutti gli alimenti di più largo consumo (quali cereali, patate,
legumi, carne, uova,
ecc.) e che può provocare perdite considerevoli di calcio (diete
rachitogene).
Per quanto riguarda le vitamine, i formaggi, unitamente agli altri prodotti
lattiero-caseari,
coprono circa il 30% della assunzione totale di vitamina B2 e di vitamina
B12, ma vantano
soprattutto, da soli, la presenza di quantità significative di vitamina A:
bastano 100 grammi
di formaggio ad assicurare circa il 50% della quantità giornaliera
consigliata per questa
vitamina.
In sostanza, di fronte agli indiscutibili pregi nutritivi dei formaggi
(notevole apporto in
energia e in proteine di elevatissima qualità, apporto abbondante e quasi
unico di calcio,
ottimo rapporto calcio/fosforo, buon apporto in vitamina A e in vitamina
B2), troviamo
alcuni difetti (contenuto in calorie e in grassi troppo elevato in alcune
varietà, grassi
prevalentemente saturi, molto sodio) che però assumono rilievo soltanto in
relazione ad un
consumo eccessivo, facilitato eventualmente dal gusto attraente di questi
prodotti e dalla
facilità con la quale a volte vengono consumati in aggiunta ai pasti
normali, proprio in
quanto pronti all'uso.
L'unico vero problema è quindi quello di utilizzare correttamente i
formaggi, in relazione
non soltanto al loro apporto nutritivo ma anche alla molteplicità di tipi
disponibili (comprese
le nuove varietà a ridotto tenore in grassi), alla loro elettiva indicazione
per l'età evolutiva e
per le intolleranze al latte, alla loro attitudine a completare le diete
vegetariane e
comunque a sostituire vantaggiosamente le carni, ecc.
Il formaggio giova a tutti
L'uso del formaggio ai pasti è molto esteso: come antipasto, come condimento
(formaggio
grattugiato), come base per piatti elaborati e squisiti.
Niente completa e arricchisce meglio un pranzo, quanto l'apparire di un
vassoio di
formaggi diversi l'uno dall'altro ma ugualmente squisiti nelle tante varietà
che hanno reso
famosa la produzione italiana.
Il formaggio è adatto a persone di tutte le età. Esso è particolarmente
indicato per i
bambini ed i ragazzi in crescita, per il suo alto contenuto di proteine, di
calcio, di grassi.
Per l'infanzia si preferiscano formaggi non fermentati, ad alto contenuto di
lipidi, il cui
sapore delicato e la cui consistenza morbida sono particolarmente accetti ai
giovanissimi.
Per gli adulti qualunque varietà di formaggio può essere adottata, ai pasti
o fuori dei pasti;
in generale si alterna l'uso di formaggio a pasta dura (per condimento) e di
formaggio a
pasta molle (per l'esecuzione di piatti particolari).
Per le persone anziane, per i bambini in tenera età e in generale per tutti
coloro cui è
consigliata una dieta a basso tenore di grassi, sono da preferire formaggi
ottenuti da latte
parzialmente scremato.
La conservazione casalinga dei formaggi
Il formaggio necessita di particolari cure per una buona conservazione se si
vuole che
mantenga intatte le caratteristiche organolettiche e la fragranza.
Va conservato in luogo fresco, in un recipiente chiuso, anche in
frigorifero, nel comparto
all'uopo destinato, per evitare che si secchi e perda il profumo.
Si eviti di conservare i formaggi vicino ad alimenti di odore forte (aglio,
cipolla, ecc.) onde
evitare che assorbano tali odori.
I formaggi si conservano più o meno a lungo, a seconda del tipo: si va dai
formaggi
freschi, che è meglio consumare entro pochi giorni, a quelli stagionati, che
possono durare
settimane.
I formaggi freschi vanno consumati entro pochi giorni dall'acquisto.
I formaggi freschi ad alto contenuto di umidità (crescenza, robiola,
mozzarella, ricotta...)
vanno privati della carta e conservati in contenitori di plastica a chiusura
ermetica, per
impedire che si secchino. Se c'è liquido di governo è bene lasciarveli
immersi. Non è
raccomandabile l'uso della pellicola per avvolgerli, perché il formaggio ha
bisogno di
spazio in cui "respirare".
I formaggi a pasta consistente, più o meno stagionati, vanno conservati
possibilmente su
un tagliere di legno, senza nessun involucro, né di carta, né di pellicola,
coperti solo da un
panno (la cosa migliore sarebbe un panno di lino) che va mantenuto
costantemente
umido. Questo accorgimento ostacola lo sviluppo di muffa: se sulla
superficie del
formaggio se ne formasse ugualmente un po', eliminatela accuratamente
raschiando in
profondità con il coltello. Non è necessario gettare via tutto il pezzo.
In tutti i casi, è molto importante la pulizia dei contenitori o del
tagliere: bisogna lavarli
frequentemente con acqua calda per rimuovere ogni traccia di grasso, che
potrebbe
irrancidire o favorire la formazione di muffe.
Non tutti sanno che i formaggi freschi si possono congelare. E' invece
sconsigliabile
congelare quelli stagionati, in particolare il grana.
Se avete problemi di conservazione, o se vi è comodo, potete acquistare
formaggi in
confezione sottovuoto o in atmosfera modificata (è un sistema più recente):
questi metodi
infatti non incidono in misura rilevante sulle caratteristiche di gusto e
profumo del
formaggio.
Formaggi d'Italia
I formaggi italiani non hanno nulla da invidiare ai più celebri formaggi
stranieri. Alcune tra
le nostre varietà tipiche vantano tradizioni antichissime e restano tuttora
inimitabili.
La qualità dei pascoli, e quindi del latte, I'accuratezza della lavorazione
e della
maturazione, un'artigianale bravura nel trattare il prodotto, sono i piccoli
segreti che danno
ad una zona geografica una specie di esclusività nella produzione di un
formaggio tipico
(Gorgonzola, Reggiano, ecc.).
Con il passar degli anni quella che era una limitata attività di fattoria è
diventata industria,
che è riuscita a mantenere quasi integri i metodi tradizionali.
La produzione di formaggi in Italia è molto varia e disseminata nelle varie
regioni, e
assume caratteristiche tipiche diverse da una regione all'altra.
Formaggi DOC e tipici riconosciuti
Asiago
Il luogo di origine di questo formaggio coincide con la zona che gli dà il
nome: l'altopiano di
Asiago. Attualmente la sua area di produzione delimitata e controllata si
estende su
quattro province: l'intero territorio di Venezia e Trento e parte dei comuni
delle province di
Padova e di Treviso.
In commercio sono reperibili due tipi di Asiago:
- l'Asiago di allevo, così denominato perché la stagionatura, condotta con
particolare cura
in appositi locali, ne costituisce un vero e proprio "allevamento". Viene
prodotto in forme di
9- 12 kg . Ha un sapore molto piccante;
- l'Asiago pressato, con sapore più dolce e delicato, derivante da una
maturazione molto
breve. Si differenzia da quello d'allevo oltre che per il sapore, per il
colore più chiaro e per
la maggiore altezza delle forme.
Bra
Prende il nome da una cittadina del cuneese dove però non viene prodotto, né
quasi mai
lo è stato. In realtà, il grosso della produzione avviene nei piccoli e medi
caseifici della
pianura cuneese e dei paesi di fondovalle. Oggi sono diffuse due qualità di
Bra: il tenero e
il duro, che si differenziano per la tecnologia di lavorazione e per la
durata della
stagionatura. In entrambi i casi le forme sono cilindriche, con un peso che
si aggira intorno
agli 8 kg .
Caciocavallo
E' un prodotto a pasta filata tipico del nostro Mezzogiorno, caratterizzato
dalla forma a
fuso con una strozzatura all'estremità superiore. Prodotto con il latte di
varie razze bovine,
quando è di razze podoliche, brade o semibrade, è particolarmente pregiato.
La sua
denominazione sembra derivi dall'accoppiamento delle provole che, legate
assieme,
venivano fatte stagionare a cavallo di un bastone orizzontale. La
stagionatura può durare
anche due anni e il sapore può essere piccante o dolce a seconda del caglio
utilizzato. I
migliori caciocavalli si segnalano nell'Alto Molise, nel Cilento,
nell'altopiano della Sila e
nell'altopiano di Verteia
Canestrato pugliese
Il suo nome deriva dai canestri entro cui lo si fa stagionare per periodi di
tempo più o meno
lunghi. Si produce in tutte le stagioni dell'anno nelle province di Foggia e
di Bari,
unicamente da latte intero di pecora di razza Merinos o Gentile di Puglia.
La pasta di
questo formaggio è compatta e friabile e le dimensioni delle forme molto
variabili, con un
peso che va dai 7 ai 14 kg .
Casciotta d'Urbino
E' un formaggio prevalentemente di pecora, prodotto tutto l'anno
nell'entroterra
marchigiano della provincia di Pesaro, oltre che nel comune da cui prende il
nome. Di
forma cilindrica, è di piccole dimensioni. La sua crosta sottile è indice di
una breve
maturazione, la sua pasta è compatta, di colore paglierino molto friabile e
di sapore dolce.
Castelmagno
E' un formaggio semi grasso pressato a pasta semidura erborinata, prodotto
prevalentemente con il latte vaccino. Si prepara nell'omonimo paese, oltre
che nei comuni
di Pradleves e Monterosso Grana (tutti in provincia di Cuneo). La sua
produzione negli
ultimi tempi è andata calando per lo spopolamento delle zone montane.
Il Castelmagno stagionato ha un sapore sapido e piccante, ma attualmente si
tende a
privilegiare un prodotto più fresco dal sapore fine e delicato,
moderatamente salato.
Fiore sardo
E' un formaggio a pasta dura cruda, prodotto in Sardegna esclusivamente con
il latte
intero di pecora, presso aziende pastorali e con metodi in uso da secoli. Il
colore della
pasta va dal bianco al giallo paglierino, mentre il sapore è gradevole e più
o meno
piccante a seconda dello stadio di stagionatura.
Appena prodotto è consigliabile come formaggio da tavola, quando ha superato
i tre mesi
si predilige come formaggio da condimento. Esternamente la sua forma
caratteristica lo
rende riconoscibile a prima vista. Alto 12- 15 cm e con diametro che va dai
12 ai 20 cm ,
assume l'aspetto di due tronchi di cono uniti per la base maggiore. La
pezzatura va da 1 a
5 kg .
Fontina
L'origine di questo nome è legato a numerose teorie, c'è chi lo collega con
l'alpeggio di
Fontin, altri lo vogliono derivato dal villaggio di Fontinaz o dal cognome
di una famiglia del
luogo. Quale sia la verità non è dato saperlo. Ma è di certo che oggi il
nome Fontina viene
rigorosamente impiegato per identificare solo e unicamente le forme prodotte
in Val
d'Aosta. La Fontina presenta una pasta morbida, ma di consistenza sostenuta
ed elastica,
ottenuta da latte crudo che non abbia subito alcuna scrematura. Il sapore
dolce presenta
variazioni anche notevoli, a seconda del grado di maturazione e dei pascoli
di
provenienza.
Il peso delle forme si aggira sugli 8- 10 kg , ma può raggiungere anche i 18
kg .
Formai de mut
La traduzione letterale del nome di questo formaggio non crea molte
difficoltà. Nel dialetto
della Val Brembana, il "mut" è semplicemente la montagna dove le mandrie
soggiornano
nei mesi estivi. E' un formaggio prezioso, in quanto raro: infatti trovarlo
al di fuori della
zona di produzione (21 comuni della provincia di Bergamo) è una vera
impresa.
La tecnica di produzione è del tutto artigianale e tutto o quasi viene
ancora fatto a mano,
come immutati sono rimasti i locali di pietra, le "casere" d'Alpe dove
avvengono buona
parte delle trasformazioni chimico-enzimatiche responsabili della buona
riuscita di questo
formaggio. La maturazione dura almeno 40-45 giorni per il tipo da consumarsi
fresco, ma
può superare anche i sei mesi di durata.
Le forme cilindriche pesano dagli 8 ai 12 kg . La pasta di color avorio è
compatta ed il
sapore è delicato, e conserva la fragranza delle erbe brembane che gli
conferiscono un
caratteristico aroma.
Gorgonzola
Fino agli inizi del secolo questo formaggio era chiamato semplicemente
"stracchino verde"
e "stracchino di Gorgonzola" e fu solo dopo la necessità di distinguere e
valorizzare il
formaggio prodotto nella zona tipica di origine a dargli il definitivo nome
di "Gorgonzola".
La sua area di produzione comprende le province di Brescia, Bergamo, Como,
Cremona,
Cuneo, Milano, Novara, Pavia, Vercelli ed il territorio di Casale Monferrato
in provincia di
Alessandria.
Preparato con latte intero, la pasta è molle, traslucida e burrosa, di
intensissimo profumo,
di gusto molto forte e pungente. Le forme hanno un peso variabile tra i 6 e
i 12 kg .
Grana padano
Ha origini remotissime, infatti è uno tra i pochi formaggi che si prepara a
festeggiare il
millennio di età. Il nome gli viene dalla struttura granulosa che lo
differenzia dalle morbide
paste degli altri formaggi, lisce e regolari al taglio.
L'area di produzione si estende dal Piemonte alla Lombardia (esclusa Mantova
a Sud del
Po), all'Emilia Romagna (escluse Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna a
sinistra del
Reno), al Veneto (esclusa Belluno) e al Trentino. E' di pasta dura-compatta,
di colore giallo
chiaro, di caratteristico aroma, di sapore intenso e gradevole. E' prodotto
dall'aprile al
novembre in forme cilindriche di 25- 40 kg . Basilare è la stagionatura e
l'invecchiamento da
un minimo di un anno ad un massimo di due anni.
Montasio
Il nome è legato alla montagna. Deriva infatti dall'omonimo rilievo delle
Alpi Giulie, ancora
oggi caratterizzato da splendidi e ricchi pascoli.
Fanno parte della zona di produzione: Friuli Venezia Giulia, le province di
Belluno e
Treviso, parte di Padova e Venezia. Le forme cilindriche hanno un altezza di
6- 10 cm ed
un peso che varia dai 5 ai 9 kg . A pasta compatta, ha un sapore tipicamente
dolce nel tipo
"fresco" che diviene aromatico e leggermente piccante nelle forme più
stagionate.
Mozzarella di bufala
E' un formaggio fresco a pasta filata ottenuto direttamente dal latte intero
di bufala,
attentamente selezionato da allevamenti che ne garantiscono la freschezza e
la genuinità.
Attualmente la maggior parte degli allevamenti di bufale è localizzata nel
Meridione,
tuttavia altri allevamenti stanno sorgendo anche al nord, fra il Ticino e il
Mincio. La
mozzarella, quando è autenticamente bufalina è "di colore bianco
porcellaneo, di forma
globosa, con una consistenza leggermente elastica nelle prime 8-10 ore dopo
la
caseificazione e poi sempre più fondente. Al taglio lascia scolare sierosità
biancastre dal
profumo di fermenti lattici".
Il sapore è gradevolmente fresco, acidulo e fragrante. E' preparata in forma
rotonda e non
supera normalmente il peso di 500 g .
Murazzano
E' una "robiola piemontese", cioè un formaggio prodotto con latte vaccino ed
ovino, di
consistenza molle, grasso a pasta morbida e fresca, un tempo prodotto quasi
esclusivamente in modo artigianale, oggi largamente prodotto da piccoli
caseifici
cooperativi di Murazzano (da cui prende il nome) e da alcuni altri comuni
della provincia di
Cuneo.
Il suo aspetto è decisamente caratteristico, con forme cilindriche che non
superano il
decimetro e mezzo di diametro.
Parmigiano reggiano
Il nome indica il legame di questo formaggio con le terre circostanti le
città di Parma e di
Reggio Emilia.
Fra le peculiarità e le attenzioni che caratterizzano la tecnica produttiva
del Parmigiano
reggiano, una delle più importanti è la cura che viene posta nella scelta
della materia
prima. Il latte deve infatti provenire da bovine perfettamente sane, la cui
alimentazione
base è costituita da foraggi di prato polifita o da medicaio. Tutta la
produzione proviene da
un'area ristretta alle province di Modena, Parma e Reggio Emilia e parte di
quelle di
Bologna e Mantova.
Come per il Grana, anche il Parmigiano ha misure più che rispettabili: dai
24 ai 40 kg di
peso. Inconfondibile è pure la struttura della pasta: granulosa, con tipica
frattura a scaglie
e un particolare aroma fragrante e delicato.
La stagionatura va da 1 a 3 anni.
Pecorino romano
Oggi è prodotto industrialmente, un tempo lo preparavano i pastori con latte
intero di
pecora. Benché i dintorni di Roma abbiano costituito la culla della
lavorazione industriale
del Pecorino, sin dal secolo scorso fu la Sardegna a divenire il centro di
maggior
produzione. E infatti benché "romano", questo Pecorino proviene in gran
parte da questa
regione, dove le tecniche di lavorazione ad esso connesse furono diffuse ad
opera di
alcuni intraprendenti imprenditori romani e napoletani.
La pasta interna, di colore bianco paglierino tenue, si presenta
generalmente compatta o
con una leggerissima occhiatura: l'aroma è fragrante, caratteristico, e il
gusto tipicamente
piccante. La stagionatura è lunga e deve protrarsi per almeno 8 mesi.
Pecorino sardo
E' un prodotto caseario semicotto che vanta un'antica tradizione e la cui
produzione è
diffusa su tutto il territorio isolano. Anche la materia prima è più che
tradizionale: il latte
della pecora di razza sarda. E' ad essa che si deve il sapore carico di
aromi che
contraddistingue il prodotto finale.
Sono due i "tipi" di Pecorino: il "Pecorino sardo dolce" e il "Pecorino
sardo maturo". Nei
due casi l'aggettivo finale sta a indicare nel primo una caratteristica del
sapore e nel
secondo i maggiori tempi di stagionatura. La pasta è bianca, morbida,
compatta o con
rada occhiatura.
La forma, che si ispira al tradizionale modello cilindrico, ha un peso
compreso tra 1 e 2 kg .
Pecorino siciliano
Detto anche "Canestratu". Prodotto esclusivamente con il latte di pecora,
molto spesso
può presentarsi nella versione con il pepe nero aggiunto, a grani interi, al
momento
dell'incanestratura. In tal caso si chiama semplicemente "pipatu". Il suo
odore è forte e
caratteristico, ed il sapore, con l'età, si fa più piccante e ricco di
aroma. Ha pasta compatta
bianca o paglierina.
La forma a ruota ha le facce leggermente concave ed un peso che va dai 4 ai
15 kg .
Pecorino toscano
Si ottiene dal latte di pecora. Viene prodotto in Toscana e in alcuni comuni
limitrofi
dell'Umbria e del Lazio. Condizioni ambientali e tecniche produttive
conferiscono al
Pecorino toscano il carattere dell'eccellenza, che raggiunge i picchi nelle
produzioni dei
mesi primaverili, quando i pascoli sono più ricchi di essenze. A pasta molle
giallopaglierino,
può essere usato fresco o anche stagionato.
Pressato
E' a base di latte crudo più o meno scremato. I produttori ed i consumatori,
non sempre gli
attribuiscono il proprio nome. Anzi localmente il destino del pressato è di
avere assunto
nomi diversi: per esempio "Gresal" a Sedico, o "Cherz" a Livinallongo. In
tal modo il nome
pressato, così com'è, senza altri attributi, ha finito per diventare niente
più che l'appellativo
di una categoria di formaggi. Si produce nelle province di Belluno e Verona
in particolare,
oltre che nelle province di Treviso, Venezia e Padova. E' a pasta gialla o
paglierina con
occhiature piccole, con una stagionatura massima di 2 mesi.
Provolone
Il nome non ha una derivazione precisa. L'etimologia, secondo alcuni, fa
pensare alla
parola napoletana prova-provola con cui in Campania viene indicato il
classico latticino di
bufala a pasta filata, da consumarsi fresco. Tuttavia localmente il termine
provolone è
spesso sostituito da nomi tradizionali che fanno riferimento alle diverse
forme e dimensioni
con cui viene preparato (Provolone, Giganti, Gigantini, ecc.). La forma
caratteristica più
comune è comunque tronco-conica, con leggere insenature per il passaggio
delle funi
utilizzate per appendere a coppie i formaggi a stagionare, ed un peso che si
aggira
mediamente sui 4- 5 kg . Di origine meridionale, la sua lavorazione è estesa
a molte regioni
italiane. Attualmente l'area di maggiore produzione si concentra nel Veneto
e in
Lombardia, in particolare nella provincia di Cremona. Il sapore della pasta
può essere
piccante o dolce; tale diversificazione è legata alla stagionatura che dura
al massimo un
anno e alla tecnica di produzione che utilizza nel primo caso il caglio in
pasta di capretto e
nel secondo il caglio liquido di vitello.
Ragusano
Viene prodotto nell'omonima città, da latte intero di mucca. La pasta è
compatta e
morbida, gustosissima, dal colore leggermente giallognolo, con una sottile
crosta dal tenue
colore biondo-paglierino.
E' un formaggio dalla forma rettangolare alto 13- 15 cm , lungo 40- 45 cm e
con un peso che
varia dai 6 ai 12 kg . Tali dimensioni giustificano il termine di
identificazione dialettale
"scaluni", che in Sicilia significa appunto "scalino".
La stagionatura dura al massimo 6 mesi. Prima di tale periodo può
considerarsi "da
tavola".
Raschera
Ufficialmente il nome gli deriva dal lago Raschera, alle falde del monte
Mongioie, in
provincia di Cuneo, che rappresenta la principale area di produzione. E' un
formaggio
semigrasso, pressato, prodotto con latte vaccino, eventualmente addizionato
con piccole
quantità di latte ovino o caprino. Se ne distinguono due forme con un peso
variabile dagli 8
ai 10 kg per quella quadrata, fino a 7- 9 kg per quella rotonda. La
stagionatura minima è di
30 giorni, ma può durare fino a 3 mesi, facendo acquistare al formaggio un
sapore più
piccante ed un aspetto esteriore leggermente diverso: la crosta assume un
colore
giallastro tendente al grigio.
Robiola di Roccaverano
Prende il nome dalla cittadina omonima in provincia di Asti. L'area di
produzione
comprende, oltre a Roccaverano, il comune di Acqui Terme e pochi altri. Un
tempo
prodotta con solo latte caprino, oggi conserva questa componente insieme con
quella di
latte ovino e vaccino (la cui percentuale non supera l'85%).
Si può consumare fresco o lasciar maturare fino a 20 giorni. Si presenta con
una forma
cilindrica ed un peso che normalmente non supera i 300 g . La crosta è
inesistente, la
pasta è tenera, leggermente biancastra o giallo tenue. Ha un sapore dolce,
fondente.
Taleggio
Fa parte dell'affollato gruppo dei prodotti tipici la cui denominazione è
strettamente
collegata alla zona di origine. E' infatti dalla Val Taleggio - in provincia
di Bergamo - che
questo formaggio originariamente proviene. La zona di produzione è
circoscritta ad alcune
province lombarde, alla provincia veneta di Treviso e a quella piemontese di
Novara.
Viene prodotto con latte vaccino. E' di pasta bianca e molle, leggermente
filante. Ha
bisogno di 25-30 giorni di stagionatura.
Viene venduto in forme rettangolari del peso di circa 2 kg .
Toma
Di incerta etimologia, si può comunque supporre che il termine abbia origine
nel francese
antico "tumer" (cadere), riferendosi alla precipitazione che la caseina
subisce nel latte per
azione del caglio. La Toma è prodotta in Val d'Aosta e in Piemonte. E'
definito come
"formaggio a pasta dura, semigrassa, prodotto con latte vaccino o misto, non
fermentato",
ma in realtà sotto questo nome sono compresi molti prodotti diversi per
stagionatura,
pezzatura, aroma e sapore (dal dolce al molto piccante). Le forme,
cilindriche, non
superano i 3 kg .
Prossimi riconoscimenti:
Bitto della Valtellina (Lombardia)
Casolet della Val Camonica (Trentino e Lombardia)
Monte Veronese (Trentino e Veneto)
Quartirolo lombardo (Lombardia)
Silter della Val Camonica (Lombardia)
In lista d'attesa:
Bagoss di Bagolino (Lombardia)
Bettelmatt della Vald'Ossola (Piemonte)
Branzi dell'Alta Val Brembana (Lombardia)
Bruss delle Langhe (Piemonte)
Burrata delle Murge (Puglia)
Cacioricotta lucana (Puglia, Campania, Basilicata)
Casieddu di Moliterno (Basilicata)
Elva o Casale de Elva (Piemonte)
Formaggio di Fossa di Sogliano (Emilia Romagna, Marche)
Formaio Embriago (Veneto)
Graukase della Valle Aurina (Alto Adige)
Mascarpone di Battipaglia (Campania)
Paglierina di Rifreddo (Piemonte)
Pecorino di Filiano (Basilicata)
Piacintinu di Enna (Sicilia)
Provula di Floresta (Sicilia)
Salato morbido del Friuli (Friuli)
Scamorza Molisana (Abbruzzo, Molise)